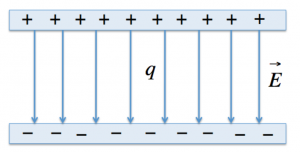“Un grande maestro del Novecento”: così recita la fascetta del ponderoso volume La pittura e lo sguardo. Scritti sull’arte, pubblicato da Neri Pozza, che raccoglie integralmente le riflessioni da teorico e storico dell’arte del pittore Avigdor Arikha, nato nel 1929 e morto nel 2010, sulla cui vita, però, occorre soffermarsi.
Il luogo esatto della sua nascita si colloca nelle vicinanze della cittadina di Radauti (facente parte del ducato asburgico di Bukovina fino alla sua dissoluzione, alla fine della Prima guerra mondiale, quando fu acquisita dalla Romania), ma la famiglia Arikha, con il piccolo Avigdor, si trasferì presto nella vicina Czernowitz, quella che è oggi l’ucraina Chernovtsy, città di lingua tedesca che si era guadagnata gli appellativi di “Piccola Vienna” e “Gerusalemme sulla Prut”, dal nome del fiume che le scorre accanto e in virtù della sua multietnicità, essendo abitata da ebrei, ruteni, romeni, tedeschi, ucraini e polacchi: Czernowitz manteneva un’intensa vivacità culturale, e tra gli artisti cui diede i natali possiamo ricordare Gregor von Rezzori, Paul Celan e Aharon Appelfeld, ma fu risucchiata nel gorgo della storia del secolo, quando passò dall’Unione Sovietica, nel giugno del 1941, nelle mani della Germania nazista, in seguito alla rottura del patto di non aggressione tra le due potenze.
Da allora, e nel corso del successivo inverno, cominciò la deportazione della locale comunità ebraica verso est, verso la Transnistria, in condizioni climatiche estreme: il padre di Avigdor morirà prima della cattura, mentre la moglie, Avigdor e sua sorella saranno internati nel campo di transito di Mogilev Podolskiy, sul fiume Dnestr. Il ragazzo ha tredici anni e un album da disegno, grazie al quale inizia a trasferire su carta le scene di miseria e disperazione alle quali è costretto ad assistere.
Quei disegni saranno la sua salvezza, perché il suo talento sarà notato dalla Croce Rossa, che lo metterà in salvo insieme alla sorella e lo imbarcherà alla volta di Israele, dove vivrà lavorando nel kibbutz di Maaleh Hahamisha e frequentando la scuola d’arte Bezalel di Gerusalemme, che poteva vantare docenti di livello come l’espressionista Isidor Ascheim e che era diretta da Mordecai Ardon, allievo di Klee e Kandinsky al Bauhaus degli anni Venti. Gli anni Cinquanta, però, vedono Arikha già attivo a Parigi, dove si era trasferito grazie a una borsa di studio dell’École des Beaux-Arts e per studiare filosofia alla Sorbona con Jean Wahl.
Perché tutte queste informazioni biografiche, che traggo dall’ampio saggio introduttivo della curatrice e traduttrice Monica Ferrando? In ragione del fatto che Arikha può davvero ritenersi rappresentativo dell’intero Novecento, nonostante la sua produzione artistica occupi ovviamente soltanto la sua seconda metà: è nella sua vita di adolescente, infatti, che fu costretto a subire in prima persona gli orrori ideologici di quell’altra porzione di secolo. A Parigi, Arikha aderirà subito all’astrattismo, raggiungendo rapidamente la fama internazionale, a partire dall’inizio degli anni Sessanta. Alla metà di quel decennio, però, la conversione: l’incontro con l’arte di Caravaggio, nel 1965, costituirà un vero e proprio shock che, nel giro di pochi giorni, farà avvertire ad Arikha molti dubbi sulla scelta modernista, nonché la necessità di recuperare un rapporto con la tradizione.
La riscoperta internazionale del pittore italiano era avvenuta a partire dal 1951 per merito di Roberto Longhi, con la mostra milanese su Caravaggio e i caravaggeschi, in un contesto europeo che sembrava interessarsi unicamente alle tendenze sperimentali più chiacchierate. Clamorosa, di conseguenza, fu la reazione di colleghi e pubblico all’allestimento parigino del 1967 in cui Arikha esponeva i primissimi frutti del nuovo corso del proprio lavoro, di quella rinascita artistica che comporterà il suo isolamento dalla critica più influente e da un mercato in sviluppo e molto prospero.
L’amicizia stretta con Samuel Beckett, che proseguirà fino alla sua morte, lo spingerà a proseguire sulla strada intrapresa, rassicurato dal sostegno offerto dall’amico irlandese e confermando, assieme al ripudio dell’avanguardia, il ritorno al disegno d’osservazione, al disegno dal vero. Arikha ha in mente altre rotture, nel compiere la propria: quella di Alberto Giacometti, in particolare, che aveva abbandonato i surrealisti, attirandosi ostilità e disprezzo, tanto da meritare l’accusa di essere diventato “impressionista”, cioè di essersi macchiato di quella che, ai loro occhi, era la colpa peggiore.
Lo stesso Giacometti aveva intravisto e favorito l’evoluzione di Arikha già dal 1949, quando ebbe a rivolgergli la seguente osservazione: “Non sei fatto per essere astratto. Non è da te; potresti metterti a disegnare; perché non lo fai?”.
La posizione di Arikha, però, non può essere facilmente etichettata come conservatrice: il suo intento, piuttosto, è quello di fare da ponte per la necessaria unione di tradizionalismo e modernismo, e la contemporaneità che gli è cara, con la quale si era misurato e della quale aveva accettato la sfida avanguardistica, è quella consapevole tanto delle proprie radici quanto della lezione novecentesca. “Mi convince l’immagine del salire sulle spalle dei giganti. Mi convince il fatto che servono le spalle dei giganti per andare avanti, a differenza del credo modernista della tabula rasa”: Arikha tiene molto alla definizione di “artista figurativo post-astratto”, rigettando quella di esponente di un “ritorno alla figurazione”, perché gli consente di non rimuovere il significato storico dell’astrazione, la quale è parte integrante della tradizione pittorica fin dai suoi primordi, e di non essere annesso alla schiera dei reazionari, capitanati in quegli anni da Hans Sedlmayr, uno degli ultimi esponenti della Scuola di Vienna, autore di un libro pubblicato nel 1948 e che circolò diffusamente nell’Europa post-bellica,Verlust der Mitte, tradotto in inglese nel 1957 con l’icastico titolo di Art in Crisis.
In seguito, il testimone dell’anti-modernismo critico passerà tra gli altri a Jean Clair, che seguirà con l’attenzione dovuta lo svilupparsi del percorso artistico di Arikha. Che cos’è il gesto di Arikha? Attraversare il proprio tempo, accettando la sfida di competere sul terreno stesso dei propri contemporanei, seguire le indicazioni dell’epoca, essere compiutamente astrattista, per tornare sui propri passi, sui passi dell’intera tradizione artistica, che “non deve essere ripetuta”: imparare e purificarsi, vincere e rifiutare, primeggiare e ritirarsi in sé stessi, a contatto con ciò che è più prezioso, il bisogno espressivo più individuale e singolare.
Un movimento simile, di apprendimento esterno e rifugio interno, ispirava certe confessioni di Montaigne, che di quelle espansioni e contrazioni faceva quasi il ritmo di un’intera grammatica esistenziale: leggere tanto e dimenticarsi quasi tutto, misurarsi sulle prove che ci vengono sottoposte dai nostri colleghi e rivali per depotenziarle e volgerle ai nostri fini, grazie all’esempio della creazione artistica che ne seguirà. (Un insegnamento, quello dei Saggi, che rivive, tanto per fare un nome su tutti, nell’itinerario letterario del nostro Goffredo Parise: prima di giungere alla composizione dei Sillabari, lo scrittore vicentino ha dimostrato come gli fosse servito immergersi nella foschia del contesto, avvicinarsi persino alle mode più in voga, per poi liberarsi, sottrarsi a tali ansie, al fine di restaurare una relativa verginità dello sguardo e della penna, una sorta di Satori esistenziale raggiunto al termine di un esercizio koan dello Zen.)
Contro le “certezze ideologiche di un modernismo effimero” in cui “la nozione di nuovo ha sostituito quella di bello” e contro la confusione critica che interpreta ciascuna moda come un’ennesima, doverosa, dose di modernità, Arikha procede alla riscoperta personale ed emotiva di artisti del passato come il già citato Caravaggio, Rubens (“pittore immenso”, nonché “uno dei più grandi disegnatori di tutti i tempi”, talenti distinti che raramente coincidono e che in lui si realizzano grazie all’eccezionalità del tratto) e Velázquez, cioè colui che nel corso di tutto l’Ottocento fu considerato “il pittore dei pittori”, e che per tale motivo è stato a lungo osteggiato: “Il suo linguaggio pittorico, teso essenzialmente a esprimere il visibile, non oltrepassa mai il mezzo espressivo. Velázquez coglie il vissuto con la pittura e non cerca, come la maggior parte dei suoi contemporanei, di ingannare lo sguardo. La credenza, propria dei suoi contemporanei, secondo la quale la pittura deve far credere alla realtà di quel che non c’è, egli non la condivide per nulla”. Una mimesi anti-illusionistica, insomma, quella del pittore spagnolo, che sembra incontrare la necessità espressiva di Arikha, la cui sensibilità a tali richiami del passato figurativo è facilmente comprensibile: da quella memoria universale egli è in grado di estrarre il proprio realismo, e a quella associa il ricordo personale dei propri disegni dal vero, abbozzati da ragazzino durante la permanenza forzata nel campo di Mogilev Podolskiy.
L’intero Novecento viene passato al vaglio della problematizzazione di Arikha, che andrà radicalizzandosi fino ad avere come bersaglio gli sforzati e stanchi proclami propagandistici dell’arte del secondo Novecento, emanati da una successione insensata di avanguardie che non smettono di imporsi attraverso gesti auto-affermativi capaci di incutere timore e rispetto: un concetto stesso, quello di avanguardia, “autodistruttivo per il fatto che si fonda sulla novità, che è una spirale senza fine” e capace di “infiammare i cuori della maggior parte degli studenti di belle arti”. Nell’esasperarsi delle operazioni di presunta rottura, di parossistico e sbandierato rinnovamento, proprie di gruppi abili nell’occultare la propria natura di “emanazioni della moda, inganni”, il pittore e saggista vede l’instaurarsi del dominio di un aesthetically correct, una severa precettistica cui adeguarsi per ottenere i favori della critica più corriva e di un pubblico avido di stupori e sensazioni estreme.
È l’audacia, concetto-chiave che regola il funzionamento delle avanguardie, nonché unico attributo che si richiede all’opera d’arte, a produrre uno scenario inedito: “Mai il brutto ha avuto tanto successo quanto ai nostri giorni. Questa conversione dei criteri di giudizio dell’arte, apparsa soprattutto dopo gli anni Sessanta, è senza precedenti nella storia”.
Proprio nei decenni successivi, infatti, via via che la spirale modernista andrà intensificandosi, il pessimismo di Arikha si farà più pressante, fino al parallelismo che sembra condensare un’intera esistenza, artistica e non, alla tesi fortissima – non inedita, anzi ampiamente visitata in sede storiografica e filosofica – dell’omologia che lega i totalitarismi politici alle avanguardie novecentesche, grazie al concetto di maniera o “stile collettivo”: “Le tirannie, siano esse religiose, politiche oppure quelle dettate dalla moda, non ammettono assolutamente la soggettività. Nel corso della storia questi periodi sono ricorrenti e impongono uno stile tipico, uno stile collettivo”, cioè una concrezione conformistica con cui esse impongono il potere che addomestica i cittadini e sudditi tanto quanto i sedicenti ribelli di varie provenienze artistiche. Diversamente, è dai tormenti della propria individualità che continuerà a prendere forma ogni esperienza autentica che sappia contrastare l’uniformità del proprio tempo, l’omologazione che “democraticamente” promette onori e favori a chiunque sia disposto ad accettarla e promuoverla, ben sapendo che “l’arte non evolve in forza di manifesti o dichiarazioni”, ma che “opera in se stessa delle rivoluzioni grazie a solitudini, non a compagnie simili all’avanguardia militare”.
Probabilmente, Arikha confidava in un unico antidoto, valido tanto per i mali politici della prima metà del secolo quanto per le tirannie artistiche dei decenni a noi più vicini, e basterà leggere il suo “Progetto di riforma per l’insegnamento delle belle arti”, una relazione redatta nel 1971 e destinata a Jacques Duhamel, l’allora ministro della Cultura, per capirne la natura e la rilevanza: “Il disegno rapido (schizzo) non avrà soggetto imposto: agli allievi basterà munirsi di un album per schizzi, che porteranno sempre con sé. Sarà praticato ovunque e in assoluta libertà”. La libertà, già: quella che lui aveva avuto, avendola ritagliata, guadagnata, conquistata, nel luogo della sua massima negazione, il campo di concentramento.
L'articolo Un ragazzino che disegna, da solo: Avigdor Arikha proviene da minima&moralia.